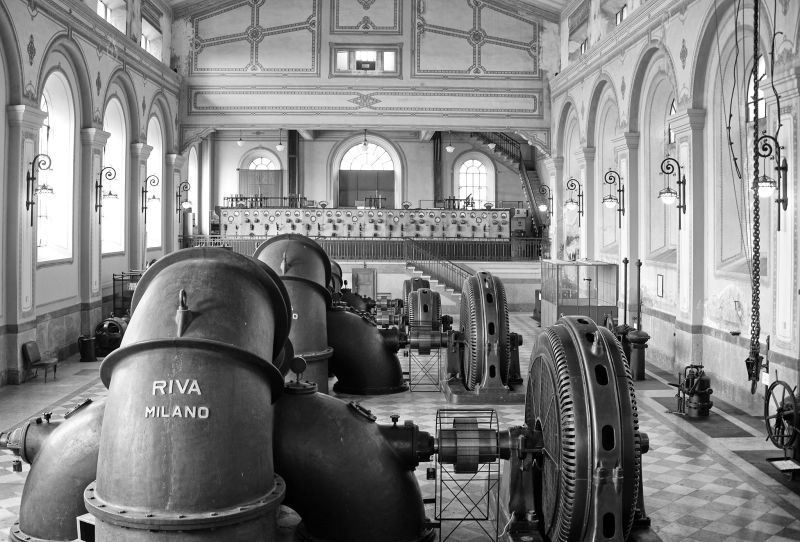
Il sovraindebitamento ai tempi di Hammurabi. E altre noterelle minime di diritto babilonese
Pubblicato il 14/11/18 00:00 [Articolo 1629]
1. Premessa
Nell'accingermi a trattare (pur con la massima umiltà che dovrebbe accompagnare tutti coloro che si occupano di materie di cui sanno praticamente niente e che, di più, sono quasi universalmente ignote) una serie di norme del codice di Hammurabi[1], confesso la vivissima preoccupazione per la mia ignoranza e, al contempo, il sollievo che mi deriva dalla convinzione che difficilmente, tra i miei ventiquattro[2] lettori, saranno molti coloro che potranno contestare seriamente le mie affermazioni.
Credo, poi, sia dovuta una pur breve spiegazione circa la genesi di questo contributo: ebbene, essa va rinvenuta nella casuale scoperta di una sorprendente somiglianza tra due norme in tema di sovraindebitamento, distanti nel tempo quasi quattro millenni: l'art. 117 del Codice di Hammurabi e il combinato disposto degli artt. 14-quinquies, comma 4 e 14-ter, comma 6, lettera b) della legge sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento[3]. Pur con inevitabili differenze (riflettenti la ben diversa temperie culturale e sociale), le due norme presentano un'innegabile parallelismo e, ancor più stranamente, nel raffronto, la norma dell'antichità non sfigura. Ma non anticiperò il tema: al paziente lettore, se avrà il tempo e la voglia di seguirmi, scoprire di che si tratti.
2) L'inadempimento del debitore e la sua responsabilità
Costituisce un cardine del diritto delle obbligazioni la regola dettata dall'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è responsabile dell'inadempimento delle sue obbligazioni e ne è liberato soltanto se l'inadempimento non sia a lui imputabile; ciò che, si sostiene pacificamente, può predicarsi soltanto in caso di caso fortuito o forza maggiore. In altri termini, la responsabilità del debitore è esclusa soltanto nel caso in cui la prestazione si riveli impossibile e, peraltro, si badi bene, soltanto se tale impossibilità abbia natura obiettiva e assoluta, i.e. l'impossibilità non dipenda dalla condizione soggettiva o da vicende personali del debitore[4]. Così, se il debitore perde il lavoro, la moglie si ammala, nessuno gli fa più credito e non dispone di denaro per poter pagare le rate del mutuo contratto, questa non è certamente un'impossibilità oggettiva; la prestazione potrebbe essere eseguita da altri, da chiunque disponga dei mezzi necessari e il debitore, divenuto insolvente, non è certamente liberato.
E in diritto babilonese[5]?
L'art. 48 del Codice di Hammurabi[6] così stabilisce:
"Se un uomo ha contratto un debito e non può pagare un creditore per mancanza di raccolto dovuta ad inondazione o siccità, non sia vincolato dal contratto e non paghi interessi per quell'anno"
Nella fattispecie regolata, l'impossibilità della prestazione non è certamente oggettiva, bensì soggettiva; il debitore non è, personalmente, in grado di adempiere perché vicende atmosferiche avverse (ma, si badi bene, non straordinarie: inondazioni e siccità non erano certamente accadimenti rari) non gli hanno consentito di adempiere il suo debito. Si noti, poi, che non solo il termine di adempimento è differito di un anno, ma, per tutto tale anno, gli interessi non maturano.
3) Aliud pro alio
Un'altra regola che è ben conficcata nelle menti dei giuristi da quando riescono a superare l'esame di diritto privato è quella contenuta nell'art. 1197 c.c., a tenore della quale il debitore non può liberarsi della sua obbligazione se non eseguendo la specifica prestazione di dare cui è tenuto, per legge o per contratto[7]; se deve pagare una somma di danaro, non può liberarsi consegnando una cosa, sia pure di pari o maggior valore; nemmeno può adempiere con danaro di altra valuta, diversa da quella convenuta (se deve pagare in euro, non può consegnare il controvalore in lire turche o in bolivar venezuelani).
Vediamo che cosa dispone il codice di Hammurabi.
Art. 51:
"Se un debitore non possiede per estinguere il suo debito, può pagare il creditore con orzo o sesamo, secondo il tasso di scambio stabilito dal decreto reale"
Non hai argento (all'epoca il danaro, nel senso che intendiamo noi, non esisteva ed il mezzo di pagamento più pregiato era l'argento)? Pazienza, hai facoltà di adempiere in orzo o in sesamo. Un decreto reale fissa il tasso di cambio.
4) Tasso usurario e sanzioni
Quid iuris se il debitore non ha argento per pagare gli interessi sul mutuo ricevuto? Può pagare aliter?
E se il creditore pretende un tasso superiore al limite legale[8] (noi diremmo "usurario")?
Leggiamo l'art. 91:
"Se un debitore non può pagare il creditore con argento, ma con orzo, il creditore deve accettare il pagamento degli interessi in orzo, secondo il tasso stabilito dal decreto reale. Se il creditore pretende un tasso d'interesse superiore perde ogni diritto sulla somma prestata."
Quindi, queste le risposte:
a) se il debitore non dispone di argento con cui pagare, paghi con orzo;
b) se il creditore pretende un tasso superiore al tasso massimo consentito (hodie: "usurario"), perde ogni diritto (non soltanto sugli interessi, ma anche sul capitale: sul punto, dobbiamo dire, una debt oriented legislation ben più rigorosa dell'attuale verso le pretese eccessive dei creditori).
5) Termine di adempimento e responsabilità patrimoniale in caso d'inadempimento
In una società fondamentalmente agraria, il termine per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento[9] (e, in particolare, per la restituzione di quanto ricevuto a titolo di mutuo) è collegato ai cicli della coltivazione, così come, in diritto contemporaneo, una serie di obblighi scadono il giorno di San Martino che, per tradizione e per convenzione, segna la fine dell'annata agraria. Per i babilonesi, il termine coincide con la mietitura (che rende disponibili orzo e cereali). Donde la regola per cui capitale ed interessi debbono essere corrisposti al tempo della mietitura.
Se il debitore non è in grado di adempiere, subisce l'espropriazione del suo patrimonio, "orzo compreso".
In tal senso, si legga l'art. 70, lettera G:
"Chi riceve una somma in prestito deve restituire somma e interessi al tempo della mietitura. Se non ha da restituire deve cedere ogni suo bene, orzo compreso."
Si tratta di una regola perfettamente sovrapponibile all'art. 2740 c.c.: il debitore risponde dell'inadempimento delle sue obbligazioni con l'intero suo patrimonio; non si ravvisano sostanziali diversità tra il diritto antico e quello attuale.
6) Sovraindebitamento ed esdebitazione
Abbiamo appena visto che, non adempiendo il debitore, il creditore ha facoltà di espropriarlo di ogni suo bene.
Ma questo può non bastare. Nonostante la soggezione del debitore al potere espropriativo del creditore, il debito può restare inadempiuto, vuoi perché il valore dei beni assoggettati ad esecuzione forzata è incapiente, vuoi perché, per avventura, il debitore è del tutto sprovvisto di beni.
Leggiamo dunque che cosa prevede, in tal caso, il codice di Hammurabi:
Art. 117:
"Moglie e figlio venduti o dati a servizio (in pegno?) a causa di un debito devono essere liberati dopo tre anni di servitù."
Si badi bene: per quanto tempo il creditore poteva imporre il lavoro ai familiari, al fine di ripagare il suo credito? Qui viene il bello, perché saremmo tentati di dire "Sino a quando non l'abbiano ripagato"[10]. E invece no, la risposta è "Per tre anni; passato questo tempo, al debitore non si può chiedere altro; egli è dunque esdebitato"[11].
E qual è il regime attuale?
A norma dell'art. 14-ter, comma 6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3:
"Non sono compresi nella liquidazione:
omissis
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice ".
Da cui si ricava che i redditi, di qualsiasi natura, che il debitore trae dalla sua attività lavorativa sono destinati alla liquidazione del patrimonio (e, dunque, alla soddisfazione dei creditori), salvo quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Quindi, il debitore deve destinare i proventi del suo lavoro (salvo quanto necessario per mantenersi); non è una situazione molto diversa da quella cui erano assoggettati i familiari del debitore; essi pure dovevano ripagare il creditore con il loro lavoro; e si badi bene che si ritiene che la loro condizione non fosse, in questo periodo, di schiavi, bensì di "lavoratori a basso costo"[12].
E per quanto tempo?
Lo si ricava dall'art. 14-quinquies, quarto ed ultimo comma, della legge c.d. sul sovraindebitamento:
"La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda."
Ecco le due disposizioni cui abbiamo accennato in premessa affermando che esse presentano una sorprendente somiglianza.
Quella contenuta nella legge italiana sul sovraindebitamento è stata criticata diffusamente in dottrina, che ha parlato addirittura di una norma "non ragionevole"[13].
Se confrontiamo le due norme, la somiglianza è a dir poco stupefacente.
Trascuriamo il particolare (per vero, secondario[14]), secondo cui a dover prestare l'opera per indennizzare il creditore non è tanto il debitore, capofamiglia[15], quanto moglie e figli. Ciò che rileva è la disposizione finale: decorsi tre anni, il debitore sarà liberato; null'altro potrà essergli chiesto. Nella sintassi del diritto contemporaneo ciò si esprime nei termini seguenti: una volta realizzata la condizione pretesa dalla legge, che consiste nel prestare l'attività lavorativa per un certo tempo a vantaggio dei creditori (salvo quanto necessario per il mantenimento), il debitore è esdebitato.
Dunque, la corvée deve durare almeno quattro anni, nel secolo XXI post Christum natum. Ai tempi di Hammurabi (diciamo, circa 3.800 anni fa ) solo tre anni.
Tra le due legislazioni, non sfugge che, con tutto quanto si ripete circa la barbarie della legge del taglione, il re Hammurabi sembra essere più clemente del legislatore attuale; e questa riflessione non può non suscitare qualche perplessità sulla bontà della tesi secondo cui la storia dell'umanità procede secondo una linea ascendente, di continua e progressiva elevazione. Del resto, un Paese che fatica a distinguere la condizione carceraria dei minori da quella dei maggiori d'età difficilmente può sperare di essere incamminato verso il progresso.
[1] E' opinione diffusa tra gli assiriologi che il codice di Hammurabi non costituirebbe un organico corpo normativo quale ai nostri giorni s'intende un codice (o anche quale intendevano i Romani le codificazioni, a partire dalle XII Tavole). Secondo A. Leo Oppenheim, L'antica Mesopotamia Ritratto di una civiltà scomparsa, Newton, 1980, 144, il codice non avrebbe avuto alcun rapporto con la pratica legale del tempo, e avrebbe avuto natura, piuttosto, di una tradizionale espressione, letteraria, delle responsabilità del re e della sua consapevolezza della diversità tra la situazione esistente e quella auspicabile. Per Daniel C. Snell, Life in the Ancient Near East, Yale University Press, 1970, 60, il codex di Hammurabi "is not really a code", quanto un documento espressivo del senso della giustizia del re. Michael Roaf, Atlante della Mesopotamia e dell'antico Vicino Oriente, De Agostini, 1992, 121, ricorda come lo stesso Hammurabi affermi come lo scopo del codice è quello di far prevalere la giustizia nel Paese, abbattere malvagi e cattivi, impedire che il forte opprima il debole; e, più oltre, suggerisce che chi vuole giustizia esamini il suo codice per trovare la regola legale da applicare; lo studioso conclude che "in realtà, non risulta che il codice fosse usato per riparare torti (se si escludono le occasionali citazioni in alcuni documenti legali di una stele che forse corrisponde a quella di Hammurabi)". Per la tesi secondo cui il codex Hammurabi è in realtà una raccolta di decisioni, per estratto, e che in accadico nemmeno esisteva una parola corrispondente alle nostre "legge" e "diritto", cfr. Jean Bottéro, Mesopotamia, The University of Chicago Press, 1992, 179 segg., secondo cui il codice è un documento di glorificazione del re, un trattato su come dovrebbe essere esercitata la giurisdizione.
[2] Non posso ambire a pareggiare il conto con infinitamente più illustri predecessori.
[3] Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221.
[4] Cfr. Cass. 15 novembre 2013, n. 25777; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462.
[5] Semplifichiamo il nostro discorso: recte dovremmo dire "nel diritto del codice di Hammurabi"; s'intende che parlando di "diritto babilonese" ci riferiamo al codice di Hammurabi, non perché non vi siano altre fonti normative dell'antica Mesopotamia, quanto perché un approfondimento comparatistico delle varie legislazioni degli antichi babilonesi (e degli assiri, degli ittiti, degli elamiti, e degli altri popoli dell'Antico Oriente) eccede ampiamente i limiti di questa indagine. Chi desiderasse approfondire può leggere Claudio Saporetti, Le antiche leggi I codici del Vicino Oriente Antico, Rusconi, 1998. Tutto questo, s'intende, al netto delle considerazioni contenute nella nota 1), cui rimandiamo, circa l'effettivo valore del codice di Hammurabi quale vero e proprio testo normativo.
[6] I testi sono tratti da Claudio Saporetti, Le antiche leggi I codici del Vicino Oriente Antico, cit., pagg. 159 segg.
[7] Art. 1197 c.c.: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta".
[8] Secondo Horst Klengel, Il re perfetto Hammurabi e Babilonia, Laterza, 1993, 213, il tasso massimo d'interesse era del 20% per i debiti in argento e del 33 e 1/2 % per i debiti in cereali (l'A. non accenna a come fosse regolata la commissione di massimo scoperto). Così, ad un dipresso, anche Michael Roaf, Atlante della Mesopotamia e dell'antico Vicino Oriente, cit., 121, secondo cui il tasso per l'argento sarebbe del 20% e, per l'orzo, del 33%.
[9] Con il termine "pagamento" ci si riferisce all'adempimento delle obbligazioni di dare: cfr. Adolfo Di Majo, in Enc. Dir., sub voce "Pagamento", vol. XXXI, Milano, 1981, 549; non necessariamente, quindi, soltanto all'adempimento delle obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro (come, invece, affermato in Trib. Roma 16 aprile 2008, in Banca, borsa e tit. cred., 2009, 732 e in Il Caso.it, pubb. 19.4.2008, secondo cui nel diritto generale delle obbligazioni con il termine "pagamento" si designa l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie). Ciò è reso palese, del resto, da alcune disposizioni normative: cfr., ad esempio, l'art. 1392 c.c., relativo al "pagamento eseguito con cose altrui". L'accezione ampia è ben presente anche nell'uso comune, in cui si suole parlare di pagamenti "in denaro", ovvero "in natura", etc. Cfr. anche Luigi Abete, Il pagamento dei debiti anteriori nel concordato preventivo, in Fall. 2013, 1112, secondo cui per "pagare" s'intende il compimento anche di un "atto solutorio di obbligazioni aventi a contenuto una prestazione di dare con oggetto res diversa dal denaro". Peraltro, l'opinione secondo cui il "pagamento" s'intenderebbe eseguito solo col denaro (o altri mezzi solutori usuali) è diffusa: cfr. Paola Vella in Massimo Ferro, Paolo Bastia e Giacomo Maria Nonno (a cura di), Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 90, che distingue tra "forme satisfattive dirette (pagamenti) o indirette (cessioni di beni, accollo, altre operazioni straordinarie, dazione di partecipazioni, obbligazioni etc.)".
[10] Questa era la regola di diritto romano: cfr. nota 11 seguente.
[11] Secondo le XII Tavole, il creditore aveva diritto di tenere presso di sé, avvinto in catene, il debitore inadempiente per sessanta giorni (stabilendosi anche il peso delle catene e la quantità di farro che doveva essergli somministrata); decorso tale termine senza che il debito fosse stato pagato, egli poteva esporlo in tre mercati consecutivi nel comizio presso il pretore, pubblicamente dichiarando la somma dovutagli, al fine d'indurre qualcuno ad adempiere all'obbligazione e così liberare il debitore; se, all'esito, il debito non era stato estinto, il creditore era libero di uccidere il debitore o di venderlo trans Tiberim (i.e. in territorio nemico); se i creditori erano più d'uno, erano facoltizzati a spartirsi il corpo del debitore insolvente ( donde la regola "concorsu partes fiunt"?); solo successivamente, il rigore della legislazione venne attenuato, prevedendosi peraltro che il debitore restasse in uno stato di prigionia di fatto, a disposizione del creditore, finché, mediante il lavoro, non avesse estinto il suo debito. Ricordiamo che la prigione per debiti, in Italia, venne meno soltanto con il codice Zanardelli del 1889.
[12] Horst Klengel, Il re perfetto Hammurabi e Babilonia, cit., 219, precisa che i familiari del debitore, sinché prestavano il loro lavoro, erano giuridicamente "liberi", salvo che non fossero già prima in condizione servile.
[13] Con previsione definita non ragionevole da Luigi Amerigo Bottai, La liquidazione del patrimonio del debitore in procedura di sovraindebitamento, in Il fallimentarista.it, pubbl. 21.12.2012, 3, anche alla luce della modifica introdotta circa la durata minima delle procedure fallimentari (in sei anni); l'A. osserva che, in difetto di concreti elementi circa il possibile occultamento di attività, non si vede perché la procedura debba essere così tanto prolungata, anche considerato che l'art. 14-novies stabilisce che "il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura". Secondo Luciano Panzani, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in Il Fallimentarista.it, pubb. 12.12.2012, 22, la Relazione governativa giustifica il termine quadriennale della procedura con l'intento di evitare l'accesso troppo facile alla procedura con l'effetto esdebitatorio che ne consegue, imponendo, conformemente alle legislazioni di altri Paesi, una soggezione per un certo tempo alle esigenze recuperatorie, a beneficio dei creditori (soluzione contestata dall'A). Anche per Remo Donzelli, Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento, in Dir. fall. 2013, I, 625, nota 54, la previsione per cui la procedura non può avere durata inferiore a quattro anni non sarebbe "condivisibile", "perché contraria all'esigenza di ragionevole durata della procedura che lo stesso legislatore evoca all'art. 14-novies, comma 1". Ad avviso di chi scrive, la ratio è invece perfettamente condivisibile: in effetti, lo scopo del prolungamento della procedura per almeno quattro anni non è tanto quello di evitare procedure affrettate, che consentano al debitore di liberarsi, strumentalmente, in tempo esiguo, delle sue obbligazioni, quanto quello di imporre al debitore un onere, se vuole conseguire la sua esdebitazione, di riservare i redditi derivanti dalla sua attività per un certo lasso di tempo (al netto di quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia) al pagamento dei crediti.
[14] Confidiamo che ai nostri ventiquattro lettori, soprattutto a quelli di genere femminile, non sfugga il tono ironico.
[15] Come suona antiquato! Ma ricordiamo che sino al 1975 (meno di 50 anni fa!), l'art. 144 c.c. così recitava "Il marito è il capo della famiglia ", così proseguendo: "la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la sua residenza".
Nell'accingermi a trattare (pur con la massima umiltà che dovrebbe accompagnare tutti coloro che si occupano di materie di cui sanno praticamente niente e che, di più, sono quasi universalmente ignote) una serie di norme del codice di Hammurabi[1], confesso la vivissima preoccupazione per la mia ignoranza e, al contempo, il sollievo che mi deriva dalla convinzione che difficilmente, tra i miei ventiquattro[2] lettori, saranno molti coloro che potranno contestare seriamente le mie affermazioni.
Credo, poi, sia dovuta una pur breve spiegazione circa la genesi di questo contributo: ebbene, essa va rinvenuta nella casuale scoperta di una sorprendente somiglianza tra due norme in tema di sovraindebitamento, distanti nel tempo quasi quattro millenni: l'art. 117 del Codice di Hammurabi e il combinato disposto degli artt. 14-quinquies, comma 4 e 14-ter, comma 6, lettera b) della legge sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento[3]. Pur con inevitabili differenze (riflettenti la ben diversa temperie culturale e sociale), le due norme presentano un'innegabile parallelismo e, ancor più stranamente, nel raffronto, la norma dell'antichità non sfigura. Ma non anticiperò il tema: al paziente lettore, se avrà il tempo e la voglia di seguirmi, scoprire di che si tratti.
2) L'inadempimento del debitore e la sua responsabilità
Costituisce un cardine del diritto delle obbligazioni la regola dettata dall'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è responsabile dell'inadempimento delle sue obbligazioni e ne è liberato soltanto se l'inadempimento non sia a lui imputabile; ciò che, si sostiene pacificamente, può predicarsi soltanto in caso di caso fortuito o forza maggiore. In altri termini, la responsabilità del debitore è esclusa soltanto nel caso in cui la prestazione si riveli impossibile e, peraltro, si badi bene, soltanto se tale impossibilità abbia natura obiettiva e assoluta, i.e. l'impossibilità non dipenda dalla condizione soggettiva o da vicende personali del debitore[4]. Così, se il debitore perde il lavoro, la moglie si ammala, nessuno gli fa più credito e non dispone di denaro per poter pagare le rate del mutuo contratto, questa non è certamente un'impossibilità oggettiva; la prestazione potrebbe essere eseguita da altri, da chiunque disponga dei mezzi necessari e il debitore, divenuto insolvente, non è certamente liberato.
E in diritto babilonese[5]?
L'art. 48 del Codice di Hammurabi[6] così stabilisce:
"Se un uomo ha contratto un debito e non può pagare un creditore per mancanza di raccolto dovuta ad inondazione o siccità, non sia vincolato dal contratto e non paghi interessi per quell'anno"
Nella fattispecie regolata, l'impossibilità della prestazione non è certamente oggettiva, bensì soggettiva; il debitore non è, personalmente, in grado di adempiere perché vicende atmosferiche avverse (ma, si badi bene, non straordinarie: inondazioni e siccità non erano certamente accadimenti rari) non gli hanno consentito di adempiere il suo debito. Si noti, poi, che non solo il termine di adempimento è differito di un anno, ma, per tutto tale anno, gli interessi non maturano.
3) Aliud pro alio
Un'altra regola che è ben conficcata nelle menti dei giuristi da quando riescono a superare l'esame di diritto privato è quella contenuta nell'art. 1197 c.c., a tenore della quale il debitore non può liberarsi della sua obbligazione se non eseguendo la specifica prestazione di dare cui è tenuto, per legge o per contratto[7]; se deve pagare una somma di danaro, non può liberarsi consegnando una cosa, sia pure di pari o maggior valore; nemmeno può adempiere con danaro di altra valuta, diversa da quella convenuta (se deve pagare in euro, non può consegnare il controvalore in lire turche o in bolivar venezuelani).
Vediamo che cosa dispone il codice di Hammurabi.
Art. 51:
"Se un debitore non possiede per estinguere il suo debito, può pagare il creditore con orzo o sesamo, secondo il tasso di scambio stabilito dal decreto reale"
Non hai argento (all'epoca il danaro, nel senso che intendiamo noi, non esisteva ed il mezzo di pagamento più pregiato era l'argento)? Pazienza, hai facoltà di adempiere in orzo o in sesamo. Un decreto reale fissa il tasso di cambio.
4) Tasso usurario e sanzioni
Quid iuris se il debitore non ha argento per pagare gli interessi sul mutuo ricevuto? Può pagare aliter?
E se il creditore pretende un tasso superiore al limite legale[8] (noi diremmo "usurario")?
Leggiamo l'art. 91:
"Se un debitore non può pagare il creditore con argento, ma con orzo, il creditore deve accettare il pagamento degli interessi in orzo, secondo il tasso stabilito dal decreto reale. Se il creditore pretende un tasso d'interesse superiore perde ogni diritto sulla somma prestata."
Quindi, queste le risposte:
a) se il debitore non dispone di argento con cui pagare, paghi con orzo;
b) se il creditore pretende un tasso superiore al tasso massimo consentito (hodie: "usurario"), perde ogni diritto (non soltanto sugli interessi, ma anche sul capitale: sul punto, dobbiamo dire, una debt oriented legislation ben più rigorosa dell'attuale verso le pretese eccessive dei creditori).
5) Termine di adempimento e responsabilità patrimoniale in caso d'inadempimento
In una società fondamentalmente agraria, il termine per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento[9] (e, in particolare, per la restituzione di quanto ricevuto a titolo di mutuo) è collegato ai cicli della coltivazione, così come, in diritto contemporaneo, una serie di obblighi scadono il giorno di San Martino che, per tradizione e per convenzione, segna la fine dell'annata agraria. Per i babilonesi, il termine coincide con la mietitura (che rende disponibili orzo e cereali). Donde la regola per cui capitale ed interessi debbono essere corrisposti al tempo della mietitura.
Se il debitore non è in grado di adempiere, subisce l'espropriazione del suo patrimonio, "orzo compreso".
In tal senso, si legga l'art. 70, lettera G:
"Chi riceve una somma in prestito deve restituire somma e interessi al tempo della mietitura. Se non ha da restituire deve cedere ogni suo bene, orzo compreso."
Si tratta di una regola perfettamente sovrapponibile all'art. 2740 c.c.: il debitore risponde dell'inadempimento delle sue obbligazioni con l'intero suo patrimonio; non si ravvisano sostanziali diversità tra il diritto antico e quello attuale.
6) Sovraindebitamento ed esdebitazione
Abbiamo appena visto che, non adempiendo il debitore, il creditore ha facoltà di espropriarlo di ogni suo bene.
Ma questo può non bastare. Nonostante la soggezione del debitore al potere espropriativo del creditore, il debito può restare inadempiuto, vuoi perché il valore dei beni assoggettati ad esecuzione forzata è incapiente, vuoi perché, per avventura, il debitore è del tutto sprovvisto di beni.
Leggiamo dunque che cosa prevede, in tal caso, il codice di Hammurabi:
Art. 117:
"Moglie e figlio venduti o dati a servizio (in pegno?) a causa di un debito devono essere liberati dopo tre anni di servitù."
Si badi bene: per quanto tempo il creditore poteva imporre il lavoro ai familiari, al fine di ripagare il suo credito? Qui viene il bello, perché saremmo tentati di dire "Sino a quando non l'abbiano ripagato"[10]. E invece no, la risposta è "Per tre anni; passato questo tempo, al debitore non si può chiedere altro; egli è dunque esdebitato"[11].
E qual è il regime attuale?
A norma dell'art. 14-ter, comma 6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3:
"Non sono compresi nella liquidazione:
omissis
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice ".
Da cui si ricava che i redditi, di qualsiasi natura, che il debitore trae dalla sua attività lavorativa sono destinati alla liquidazione del patrimonio (e, dunque, alla soddisfazione dei creditori), salvo quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Quindi, il debitore deve destinare i proventi del suo lavoro (salvo quanto necessario per mantenersi); non è una situazione molto diversa da quella cui erano assoggettati i familiari del debitore; essi pure dovevano ripagare il creditore con il loro lavoro; e si badi bene che si ritiene che la loro condizione non fosse, in questo periodo, di schiavi, bensì di "lavoratori a basso costo"[12].
E per quanto tempo?
Lo si ricava dall'art. 14-quinquies, quarto ed ultimo comma, della legge c.d. sul sovraindebitamento:
"La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda."
Ecco le due disposizioni cui abbiamo accennato in premessa affermando che esse presentano una sorprendente somiglianza.
Quella contenuta nella legge italiana sul sovraindebitamento è stata criticata diffusamente in dottrina, che ha parlato addirittura di una norma "non ragionevole"[13].
Se confrontiamo le due norme, la somiglianza è a dir poco stupefacente.
Trascuriamo il particolare (per vero, secondario[14]), secondo cui a dover prestare l'opera per indennizzare il creditore non è tanto il debitore, capofamiglia[15], quanto moglie e figli. Ciò che rileva è la disposizione finale: decorsi tre anni, il debitore sarà liberato; null'altro potrà essergli chiesto. Nella sintassi del diritto contemporaneo ciò si esprime nei termini seguenti: una volta realizzata la condizione pretesa dalla legge, che consiste nel prestare l'attività lavorativa per un certo tempo a vantaggio dei creditori (salvo quanto necessario per il mantenimento), il debitore è esdebitato.
Dunque, la corvée deve durare almeno quattro anni, nel secolo XXI post Christum natum. Ai tempi di Hammurabi (diciamo, circa 3.800 anni fa ) solo tre anni.
Tra le due legislazioni, non sfugge che, con tutto quanto si ripete circa la barbarie della legge del taglione, il re Hammurabi sembra essere più clemente del legislatore attuale; e questa riflessione non può non suscitare qualche perplessità sulla bontà della tesi secondo cui la storia dell'umanità procede secondo una linea ascendente, di continua e progressiva elevazione. Del resto, un Paese che fatica a distinguere la condizione carceraria dei minori da quella dei maggiori d'età difficilmente può sperare di essere incamminato verso il progresso.
[1] E' opinione diffusa tra gli assiriologi che il codice di Hammurabi non costituirebbe un organico corpo normativo quale ai nostri giorni s'intende un codice (o anche quale intendevano i Romani le codificazioni, a partire dalle XII Tavole). Secondo A. Leo Oppenheim, L'antica Mesopotamia Ritratto di una civiltà scomparsa, Newton, 1980, 144, il codice non avrebbe avuto alcun rapporto con la pratica legale del tempo, e avrebbe avuto natura, piuttosto, di una tradizionale espressione, letteraria, delle responsabilità del re e della sua consapevolezza della diversità tra la situazione esistente e quella auspicabile. Per Daniel C. Snell, Life in the Ancient Near East, Yale University Press, 1970, 60, il codex di Hammurabi "is not really a code", quanto un documento espressivo del senso della giustizia del re. Michael Roaf, Atlante della Mesopotamia e dell'antico Vicino Oriente, De Agostini, 1992, 121, ricorda come lo stesso Hammurabi affermi come lo scopo del codice è quello di far prevalere la giustizia nel Paese, abbattere malvagi e cattivi, impedire che il forte opprima il debole; e, più oltre, suggerisce che chi vuole giustizia esamini il suo codice per trovare la regola legale da applicare; lo studioso conclude che "in realtà, non risulta che il codice fosse usato per riparare torti (se si escludono le occasionali citazioni in alcuni documenti legali di una stele che forse corrisponde a quella di Hammurabi)". Per la tesi secondo cui il codex Hammurabi è in realtà una raccolta di decisioni, per estratto, e che in accadico nemmeno esisteva una parola corrispondente alle nostre "legge" e "diritto", cfr. Jean Bottéro, Mesopotamia, The University of Chicago Press, 1992, 179 segg., secondo cui il codice è un documento di glorificazione del re, un trattato su come dovrebbe essere esercitata la giurisdizione.
[2] Non posso ambire a pareggiare il conto con infinitamente più illustri predecessori.
[3] Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221.
[4] Cfr. Cass. 15 novembre 2013, n. 25777; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462.
[5] Semplifichiamo il nostro discorso: recte dovremmo dire "nel diritto del codice di Hammurabi"; s'intende che parlando di "diritto babilonese" ci riferiamo al codice di Hammurabi, non perché non vi siano altre fonti normative dell'antica Mesopotamia, quanto perché un approfondimento comparatistico delle varie legislazioni degli antichi babilonesi (e degli assiri, degli ittiti, degli elamiti, e degli altri popoli dell'Antico Oriente) eccede ampiamente i limiti di questa indagine. Chi desiderasse approfondire può leggere Claudio Saporetti, Le antiche leggi I codici del Vicino Oriente Antico, Rusconi, 1998. Tutto questo, s'intende, al netto delle considerazioni contenute nella nota 1), cui rimandiamo, circa l'effettivo valore del codice di Hammurabi quale vero e proprio testo normativo.
[6] I testi sono tratti da Claudio Saporetti, Le antiche leggi I codici del Vicino Oriente Antico, cit., pagg. 159 segg.
[7] Art. 1197 c.c.: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta".
[8] Secondo Horst Klengel, Il re perfetto Hammurabi e Babilonia, Laterza, 1993, 213, il tasso massimo d'interesse era del 20% per i debiti in argento e del 33 e 1/2 % per i debiti in cereali (l'A. non accenna a come fosse regolata la commissione di massimo scoperto). Così, ad un dipresso, anche Michael Roaf, Atlante della Mesopotamia e dell'antico Vicino Oriente, cit., 121, secondo cui il tasso per l'argento sarebbe del 20% e, per l'orzo, del 33%.
[9] Con il termine "pagamento" ci si riferisce all'adempimento delle obbligazioni di dare: cfr. Adolfo Di Majo, in Enc. Dir., sub voce "Pagamento", vol. XXXI, Milano, 1981, 549; non necessariamente, quindi, soltanto all'adempimento delle obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro (come, invece, affermato in Trib. Roma 16 aprile 2008, in Banca, borsa e tit. cred., 2009, 732 e in Il Caso.it, pubb. 19.4.2008, secondo cui nel diritto generale delle obbligazioni con il termine "pagamento" si designa l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie). Ciò è reso palese, del resto, da alcune disposizioni normative: cfr., ad esempio, l'art. 1392 c.c., relativo al "pagamento eseguito con cose altrui". L'accezione ampia è ben presente anche nell'uso comune, in cui si suole parlare di pagamenti "in denaro", ovvero "in natura", etc. Cfr. anche Luigi Abete, Il pagamento dei debiti anteriori nel concordato preventivo, in Fall. 2013, 1112, secondo cui per "pagare" s'intende il compimento anche di un "atto solutorio di obbligazioni aventi a contenuto una prestazione di dare con oggetto res diversa dal denaro". Peraltro, l'opinione secondo cui il "pagamento" s'intenderebbe eseguito solo col denaro (o altri mezzi solutori usuali) è diffusa: cfr. Paola Vella in Massimo Ferro, Paolo Bastia e Giacomo Maria Nonno (a cura di), Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 90, che distingue tra "forme satisfattive dirette (pagamenti) o indirette (cessioni di beni, accollo, altre operazioni straordinarie, dazione di partecipazioni, obbligazioni etc.)".
[10] Questa era la regola di diritto romano: cfr. nota 11 seguente.
[11] Secondo le XII Tavole, il creditore aveva diritto di tenere presso di sé, avvinto in catene, il debitore inadempiente per sessanta giorni (stabilendosi anche il peso delle catene e la quantità di farro che doveva essergli somministrata); decorso tale termine senza che il debito fosse stato pagato, egli poteva esporlo in tre mercati consecutivi nel comizio presso il pretore, pubblicamente dichiarando la somma dovutagli, al fine d'indurre qualcuno ad adempiere all'obbligazione e così liberare il debitore; se, all'esito, il debito non era stato estinto, il creditore era libero di uccidere il debitore o di venderlo trans Tiberim (i.e. in territorio nemico); se i creditori erano più d'uno, erano facoltizzati a spartirsi il corpo del debitore insolvente ( donde la regola "concorsu partes fiunt"?); solo successivamente, il rigore della legislazione venne attenuato, prevedendosi peraltro che il debitore restasse in uno stato di prigionia di fatto, a disposizione del creditore, finché, mediante il lavoro, non avesse estinto il suo debito. Ricordiamo che la prigione per debiti, in Italia, venne meno soltanto con il codice Zanardelli del 1889.
[12] Horst Klengel, Il re perfetto Hammurabi e Babilonia, cit., 219, precisa che i familiari del debitore, sinché prestavano il loro lavoro, erano giuridicamente "liberi", salvo che non fossero già prima in condizione servile.
[13] Con previsione definita non ragionevole da Luigi Amerigo Bottai, La liquidazione del patrimonio del debitore in procedura di sovraindebitamento, in Il fallimentarista.it, pubbl. 21.12.2012, 3, anche alla luce della modifica introdotta circa la durata minima delle procedure fallimentari (in sei anni); l'A. osserva che, in difetto di concreti elementi circa il possibile occultamento di attività, non si vede perché la procedura debba essere così tanto prolungata, anche considerato che l'art. 14-novies stabilisce che "il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura". Secondo Luciano Panzani, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in Il Fallimentarista.it, pubb. 12.12.2012, 22, la Relazione governativa giustifica il termine quadriennale della procedura con l'intento di evitare l'accesso troppo facile alla procedura con l'effetto esdebitatorio che ne consegue, imponendo, conformemente alle legislazioni di altri Paesi, una soggezione per un certo tempo alle esigenze recuperatorie, a beneficio dei creditori (soluzione contestata dall'A). Anche per Remo Donzelli, Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento, in Dir. fall. 2013, I, 625, nota 54, la previsione per cui la procedura non può avere durata inferiore a quattro anni non sarebbe "condivisibile", "perché contraria all'esigenza di ragionevole durata della procedura che lo stesso legislatore evoca all'art. 14-novies, comma 1". Ad avviso di chi scrive, la ratio è invece perfettamente condivisibile: in effetti, lo scopo del prolungamento della procedura per almeno quattro anni non è tanto quello di evitare procedure affrettate, che consentano al debitore di liberarsi, strumentalmente, in tempo esiguo, delle sue obbligazioni, quanto quello di imporre al debitore un onere, se vuole conseguire la sua esdebitazione, di riservare i redditi derivanti dalla sua attività per un certo lasso di tempo (al netto di quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia) al pagamento dei crediti.
[14] Confidiamo che ai nostri ventiquattro lettori, soprattutto a quelli di genere femminile, non sfugga il tono ironico.
[15] Come suona antiquato! Ma ricordiamo che sino al 1975 (meno di 50 anni fa!), l'art. 144 c.c. così recitava "Il marito è il capo della famiglia ", così proseguendo: "la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la sua residenza".